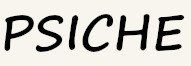Il senso di colpa
Emozione sociale complessa, fra rimorso, autocommiserazione, rabbia, tristezza, ansia e depressione
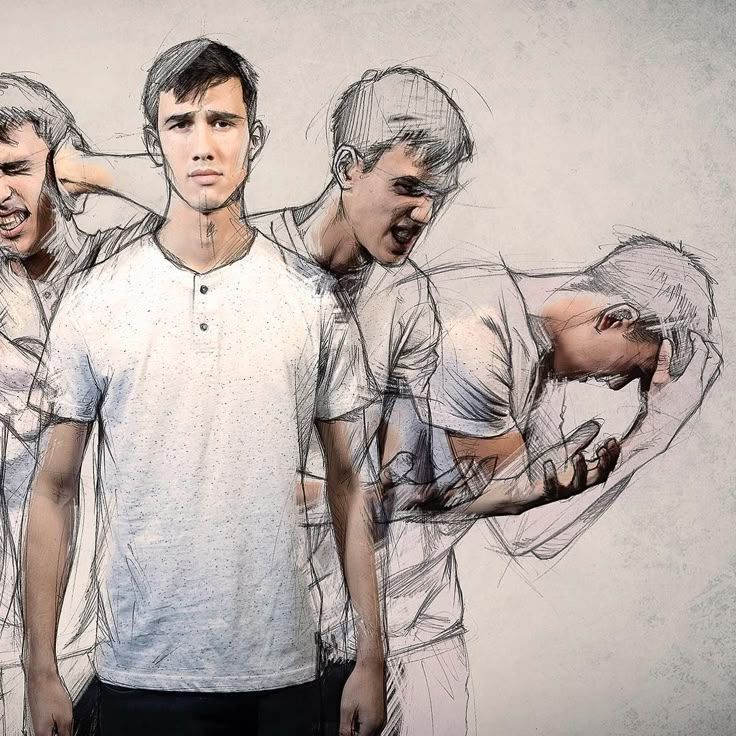
Il senso di colpa,
il peso della responsabilità.
ll senso di colpa (colpa, dal latino cŭlpa, indica un “comportamento con conseguenze dannose”) è l’emozione che si prova nel momento in cui si prende coscienza della propria responsabilità in un evento negativo, sia essa effettiva, presunta o immaginata.
Il senso di colpa è un’emozione sociale o secondaria, cioè non innata come le primarie, ma si sviluppa nel tempo, fin dall’infanzia, attraverso l’interazione sociale, e l’interiorizzazione dell’educazione dei genitori e della società.
Il senso di colpa è un’emozione complessa anche nel senso che è composta da più emozioni, in particolare da un intreccio di rimorso e rammarico, autocommiserazione, rabbia e tristezza.
É un’emozione che si attiva quando un soggetto ritiene di essere stato responsabile di un danno o di una delusione, reali o percepiti, o di aver compiuto un’azione contro i propri principi morali o le aspettative sociali, oppure quando sente di non essere all’altezza di ciò che gli altri si aspettano da lui.
Il senso di colpa - come l’imbarazzo o l’orgoglio - è definita come un’emozione auto-consapevole, in quanto implica la riflessione su di sé.
Esistono divesi tipi di senso di colpa:
a) COLPA REATTIVA: La ragione più ovvia per sentirsi in colpa è il pensare di aver fatto qualcosa di sbagliato. Questo tipo di colpa può far riferimento ad un danno fisico o psicologico a qualcun altro, alla violazione del codice etico o morale (es. tradire, mentire o rubare), a comportamenti che si ha giurato a sé stesso di non fare più (fumare, bere o mangiare troppo). È normale sentirsi in colpa, il problema è quando il pensarci diventa rimuginazione, e inficia il benessere quotidiano.
2) COLPA ANTICIPATORIA: si verifica per qualcosa che non si è fatto, ma si vorrebbe fare, quando pensare di commettere un atto contrario ai propri principi morali anche se non si ha ancora messo in atto queste azioni.
3) SENSO DI COLPA da INSUFFICIENZA, derivante dalla sensazione di non aver fatto abbastanza per aiutare gli altri. Spesso questo senso di colpa si manifesta anche quando si deludono persone care, che avevano aspettative su di noi.
4) SENSO DI COLPA “DEL SOPRAVVISSUTO”, legata alla morte degli altri appartenenti ad uno stesso gruppo o aggregato: è stato osservato nei reduci di guerra. Si verifica anche quando si perdono amici o familiari per esempio in un disastro naturale; tuttavia, questa sensazione si può provare anche semplicemente quando si hanno condizioni di vita migliori rispetto alla propria famiglia o agli amici.
5) SENSO DI COLPA ESISTENZIALE: si verifica quando una persona vive una lotta interiore con "chi è" e con "che cosa fa" e non sa quale sia il suo posto nel mondo.
In prospettiva psicodinamica, il senso di colpa nasce dal conflitto tra le nostre pulsioni e i valori morali (giusto -sbagliato, buono-cattivo) ed è dunque strettamente collegato alla coscienza morale (definita da Freud Super-Io), quella parte della psiche costituita dall’insieme delle norme e degli ideali, che sono stati interiorizzati attraverso l’educazione dalla famiglia e dalla società. Il Super-io, regolato dal principio del dovere, si trova in conflitto con l’Es, la parte più primitiva e inconscia della psiche, sede dei bisogni e delle pulsioni, regolata esclusivamente dal principio del piacere. Se il motto dell’Es è “IO voglio!”, quello del Super-io è “IO devo!”. Il senso di colpa emerge quando c’è un conflitto tra l’Es e il Super-Io: quando i desideri dell’Es non sono socialmente accettabili, vengono repressi dal Super-Io, e il senso di colpa è una delle strategie con cui opera la repressione. Un Super-Io troppo rigido può generare un senso di colpa eccessivo. Tuttavia il senso di colpa svolge un ruolo essenziale nella regolazione del comportamento umano, svolgendo una funzione adattiva. Funziona infatti come meccanismo di autocontrollo che frena e impedisce di compiere comportamenti dannosi verso gli altri, preservando in tal modo i rapporti sociali.
Il senso di colpa può essere dunque funzionale o patologico.
Il SENSO DI COLPA FUNZIONALE è un segnale che aiuta a mantenere l’equilibrio nelle interazioni sociali e nelle decisioni morali: connesso all’autocritica e all’autoconsapevolezza, spinge correggere i propri errori, a chiedere scusa o a fare ammenda.
Il SENSO DI COLPA PATOLOGICO invece è un sentimento paralizzante. Quando diventa eccessivo o irrazionale, sproporzionato rispetto all’evento che lo ha scatenato, può innescare una spirale di auto-colpevolizzazione con conseguenti stati d’animo negativi, quali bassa autostima, ansia, depressione. Qui il senso di colpa non è più legato a un errore reale o a una trasgressione concreta, ma diventa una condizione cronica che pervade la vita della persona, facendola sentire inadeguata, colpevole e perennemente responsabile del malessere altrui.
Il senso di colpa patologico è caratterizzato da:
- - AUTOACCUSA IRRAZIONALE : ci si accusa di eventi o situazioni che non derivano o non derivano totalmente da noi, come la morte di un parente, un divorzio
- - IPER-RESPONSABILIZZAZIONE : ci si sente responsabili anche per circostanze che non possono essere controllate, come se si possedesse il potere di prevedere ogni possibile eventualità negativa.
- - SENSO DI COLPA PER DESIDERI E PENSIERI : ci si sente in colpa non solo per le azioni, ma anche per i pensieri e i desideri ritenuti “sbagliati” .
Il senso di colpa patologico provoca una serie di disturbi emotivi e psicologici, quali:
- - l’ANSIA: stato di preoccupazione costante e indefinita, in cui si teme di aver fatto o di poter fare qualcosa di sbagliato. Ciò si manifesta con tutta la sintomatologia fisica associata, tra cui tachicardia, mal di testa, mal di stomaco,respiro corto e tensione muscolare e disturbi del sonno stati di irrequietezza, insonnia e difficoltà di concentrazione.
- - la DEPRESSIONE : Il senso di colpa può abbassare l’autostima e portare a sentimenti di impotenza e autocommiserazione, che portano allo stato depressivo.
- - le OSSESSIONI : ossessioni e comportamenti compulsivi (ad esempio il bisogno di chiedere costantemente scusa) che hanno lo scopo di alleviare il senso di colpa, e temporaneamente ci riescono, ma a lungo termine lo rinforzano.
- - la RABBIA verso se stessi, per aver sbagliato
- - la TRISTEZZA
- - l’ANGOSCIA
I processi cognitivi che determinano e sostengono il senso di colpa sono il RIMUGINIO e la RUMINAZIONE. Il rimuginio tiene vivo il passato nel presente analizzando in continuazione le cause delle proprie colpe e come si sarebbe potuto fare diversamente per evitarlo; La ruminazione anticipa il futuro con continue immagini sulle possibili conseguenze negative delle proprie azioni. Questo stato psichico negativo arriva a compromettere la propria vita e quella relazionale.
Esiste un senso di colpa conscio e uno inconscio. Il senso di colpa conscio è quello di cui si è consapevoli, che si identifica e si è in grado di descrivere in modo esplicito. Questo tipo di senso di colpa induce a riflettere su di sé, sulle proprie azioni e a cercare modi per porvi rimedio. Il senso di colpa inconscio, invece, non viene immediatamente identificato ed è connesso con i desideri inaccettabili e perciò repressi. Questo senso di colpa si manifesta nelle nevrosi.
In psicopatologia, il ruolo del senso di colpa è assolutamente centrale nei disturbi ossessivo compulsivi. Mentre nei disturbi di personalità antisociale può essere totalmente assente.
S. Freud, Lettere 1873-1939, Boringhieri ,1960
M. Klein, G. Meneguz, Aggressività, angoscia, senso di colpa, Bollati Boringhieri 2012
R.Fimiani, F. Gazzillo, N. Dazzi, M. Bush, Il senso di colpa del sopravvissuto: caratteristiche teoriche, empiriche e cliniche. International Forum of Psychoanalysis, 176-190.
M. Bush, Il ruolo del senso di colpa in psicopatologia e psicoterapia, 53 (2), (pag.97–107), 1989