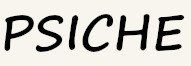La gelosia
La gelosia è un'emozione complessa che nasce dall’insicurezza e dalla paura della perdita
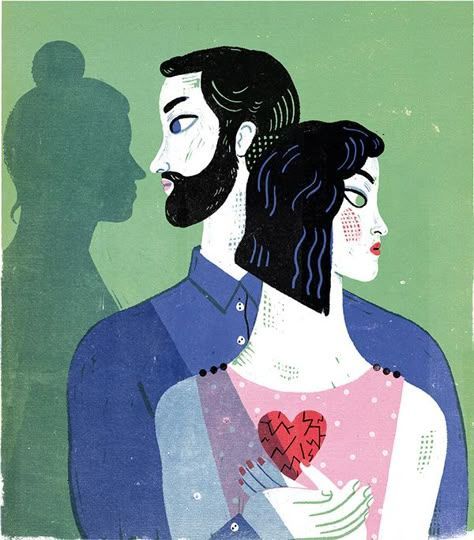
La gelosia è un’emozione complessa, una reazione alla percezione che un’importante relazione interpersonale oppure un oggetto sia minacciato da altri. Quando si prova gelosia si prova uno spiacevole stato di allerta e di minaccia di perdita di qualcuno o di qualcosa ed è pertanto associata alla paura e all’ansia.
La gelosia non si presenta solo nelle relazioni amorose, ma anche nelle amicizie, nei legami familiari e nelle relazioni professionali. È una risposta a una minaccia percepita, sia essa reale o immaginaria, che mette in crisi il proprio valore, ovvero la propria autostima, e il proprio ruolo all’interno di una relazione importante.
La gelosia non è una reazione primaria e istintiva, innata, come la rabbia o la paura, ma è un’emozione sociale, che si sviluppa in funzione delle relazioni con gli altri.
La gelosia è attivata da tre ruoli fondamentali: la persona gelosa, la persona amata e il rivale. Nella gelosia infatti il timore di perdere la persona amata insorge a causa di un rivale, anche se solo immaginario e del tutto assente. Il rivale più temuto è colui che possiede le caratteristiche positive più simili a quelle del proprio Sé ideale, piuttosto che a quello della persona amata: la persona gelosa si percepisce infatti come inferiore e inadeguata a confronto con il rivale. Le situazioni che attivano la gelosia possono essere reali ma possono anche essere il risultato della proiezione delle paure dalla persona gelosa sulla persona amata. Qualora la gelosia insorga in seguito a fatti innegabili, affiorano ulteriori emozioni: nel caso in cui la persona tradita si concentri sulla perdita, vi sarà la predominanza di emozioni legate all’ansia, alla tristezza e alla disperazione; se invece il focus è sulla menzogna e sull’infedeltà, emergeranno emozioni di rabbia e odio nei confronti del partner e del rivale.
L’intensità e il tipo di gelosia variano in base a diversi fattori: l’autostima, il tipo di attaccamento che si è instaurato da bambini con la figura curante (caregiver) e le altre esperienze affettive vissute in precedenza. In alcune situazioni, la gelosia ha una funzione adattiva, in quanto esprime il bisogno di proteggere un legame significativo e sollecita il dialogo nella coppia. Nondimeno, se ossessiva, diventa pervasiva e distruttiva, manifestandosi con comportamenti controllanti e manipolatori e corrodendo la fiducia.
In termini cognitivi la gelosia comporta un’alterazione selettiva dell’attenzione e della memoria. I processi cognitivi generati dall’emozione della gelosia, come l’attenzione selettiva, le rimuginazioni e le ruminazioni portano a inferenze che confermano la minaccia, ovvero costruiscono ad hoc le prove dell’infedeltà, alimentandola ulteriormente. L’attenzione si concentra minuziosamente e selettivamente sulla persona amata e sul rivale, sulle loro emozioni, parole e comportamenti più sospetti. Allo stesso modo i processi di memoria richiamano selettivamente solo i ricordi che convalidano il sospetto. Mentre il rimuginio (più fastidioso e orientato a prefigurare pericoli futuri) e la ruminazione (più duratura e orientata ad analizzare le cause del proprio malessere) mantengono in modo disfunzionale la gelosia. Maggiore è la rigidità e la pervasività dei pensieri minacciosi e dei processi cognitivi attivati dalla gelosia (ipervigilanza, memoria selettiva, ruminazioni e rimuginazioni, distorsioni cognitive), maggiore sarà la probabilità di riscontrarne aspetti patologici, ovvero disfunzionali.
Inoltre una caratteristica tipica della gelosia ossessiva è l’incapacità di placare l’ansia nonostante le rassicurazioni e conferme ricevute.
La gelosia patologica è caratterizzata da idee ossessive e da pensieri intrusivi, ripetitivi e incontrollabili legati al timore della perdita, dal sentimento di possesso nei confronti della persona amata e dal bisogno compulsivo di controllare (come guardare il telefono del partner, monitorare i suoi spostamenti, fare interrogatori ripetitivi, ripercorrere mentalmente situazioni passate alla ricerca di prove di infedeltà; anche azioni banali come un sorriso a un estraneo o un ritardo possono essere interpretate come segnali di tradimento). Oltre al bisogno compulsivo di controllo, il soggetto geloso può arrivare a vietare o imporre comportamenti al proprio partner. Il che può suscitare sentimenti di vergogna in chi li compie e di oppressione in chi li subisce. Nei confronti del rivale emergono invece sentimenti di annullamento, invidia e odio. Questo tipo di comportamento compromette il benessere psicologico della persona e deteriora la relazione, perché il partner si sente costantemente sotto accusa e limitato nella propria libertà.
Nella prospettiva freudiana, la gelosia ha origini profonde nell’infanzia, quando il bambino sperimenta le prime forme di competizione per l’amore e l’attenzione delle figure di attaccamento. Il complesso di Edipo, in particolare, evidenzia il desiderio del bambino di essere l’oggetto privilegiato dell’amore del genitore di sesso opposto, con la conseguente rivalità nei confronti del genitore dello stesso sesso. Questo conflitto viene rimosso nell’inconscio, ma continua a influenzare le relazioni affettive future, dove la paura di perdere l’esclusività dell’amore riattiva dinamiche infantili di possesso e competizione.
Freud distingue tre tipi di gelosia: normale, proiettata e delirante. La gelosia normale è una reazione emotiva legata alla paura della perdita ed è connessa a insicurezze e desideri inconsci. La gelosia proiettata consiste nella proiezione sul partner dei propri desideri inconsci di infedeltà, più in generale delle proprie pulsioni represse. Questo tipo di gelosia è spesso presente negli individui che, inconsciamente, nutrono attrazioni proibite e non accettate dalla loro coscienza. La gelosia delirante, infine, è quella più patologica, tipica di alcuni disturbi psicotici, e si manifesta con convinzioni ossessive e infondate di tradimento.
Dal punto di vista psicodinamico, la gelosia ossessiva è radicata in profonde insicurezze originate nelle prime esperienze relazionali nell’infanzia, ovvero nell’attaccamento insicuro. Il timore della perdita è una delle ansie più primordiali dell’essere umano. Nei primi anni di vita, il bambino sviluppa un legame di dipendenza con la figura materna (attaccamento) e sperimenta angoscia ogni volta che questa si allontana. Se le esperienze infantili hanno creato un attaccamento sicuro, l’individuo sarà più capace di tollerare la separazione e di gestire in modo equilibrato i rapporti affettivi. Se invece il bambino ha vissuto separazioni dolorose o ha sperimentato un amore instabile e condizionato, la paura dell’abbandono e la difficoltà a tollerare l’autonomia possono divenire un tema centrale nella vita adulta, alimentando relazioni caratterizzate da insicurezza e gelosia.
Al cuore della gelosia vi è dunque il conflitto tra il bisogno di sicurezza e la paura del rifiuto. Chi prova gelosia teme di essere sostituito, di non essere abbastanza o di non meritare l’amore dell’altro. Questo senso di minaccia può attivare meccanismi di difesa primitivi come la proiezione, in cui l’individuo attribuisce all’altro le proprie insicurezze e paure ( per esempio, una persona che inconsciamente cova il bisogno di essere desiderata da altri può finire per sospettare costantemente del partner, immaginando che sia lui a essere attratto da qualcun altro) .Esperienze successive di rifiuti o tradimenti, spesso auto-generate dai propri pensieri ossessivi e comportamenti controllanti e limitanti il partner, non fanno che rinforzare il sentimento di gelosia e sortiscono l’effetto opposto, allontanando il partner e confermando, in un circolo vizioso, la paura iniziale della perdita.
Se un individuo ha vissuto relazioni in cui è stato tradito o ha sperimentato la perdita improvvisa di una figura di riferimento, è più probabile che sviluppi una vulnerabilità alla gelosia. Questo accade perché la ferita emotiva non elaborata si riattiva nelle relazioni future, facendo sì che ogni segnale di possibile minaccia venga vissuto con intensità eccessiva.
La gelosia a livello profondo implica inoltre un conflitto tra amore e aggressività. Il bisogno di mantenere il possesso dell’altro si scontra con la rabbia per la sua indipendenza e con il dolore per la paura dell’abbandono. Questi sentimenti ambivalenti generano confusione e incapacità ad agire in modo equilibrato e coerente. Un esempio concreto di questa dinamica è la persona che oscilla tra idealizzazione e svalutazione del partner: da un lato, lo considera essenziale per la propria felicità, dall’altro, teme costantemente di essere tradito e finisce per trattarlo con sospetto e risentimento.
Affrontare la gelosia patologica richiede un lavoro su sé stessi per imparare a gestire i pensieri intrusivi e sviluppare l'autostima, in modo che non dipenda esclusivamente dal comportamento dell’altro. Se l’individuo non sviluppa un senso stabile del proprio valore, tenderà a cercare negli altri la conferma della propria importanza. La vera sicurezza emotiva non viene dall’esterno, ma dalla capacità di riconoscere il proprio valore senza bisogno di conferme continue. Quando ci si apprezza in modo autentico, la paura di perdere l’altro si attenua, perché non si percepisce più l’amore come un elemento da possedere, ma come un’esperienza da condividere liberamente.
La gelosia è inoltre la manifestazioni per eccellenza della condizione patologica di dipendenza affettiva. Uno degli elementi chiave nella gelosia è infatti l’incapacità di distinguere l’altro come “non -io”, ovvero riconoscere che il partner o una persona cara è un individuo separato, con pensieri, emozioni, desideri e volontà propri. Fin dalla nascita, il bambino vive in una fusione totale con la figura materna, un’unità in cui non esiste ancora una distinzione tra sé e l’altro. Questo stato di simbiosi è necessario per il suo sviluppo emotivo, ma con il tempo il bambino deve imparare a riconoscere l’altro come separato da sé. Tale capacità di differenziazione dell’altro come “non-io” è una tappa fondamentale nello sviluppo psichico e nella costruzione della nostra identità. Il processo di differenziazione inizia nei primi anni di vita ed è strettamente legato alle dinamiche dell’attaccamento, quando il bambino impara che la madre non è una sua estensione, ma un soggetto autonomo. Quando il bambino si accorge che la madre non risponde immediatamente ai suoi bisogni o che può dedicare attenzioni ad altri, inizia a percepire la sua individualità. Questa scoperta provoca frustrazione, ma è anche il primo passo per lo sviluppo dell’autonomia e dell’identità. Se il bambino cresce in un ambiente in cui l’altro è riconosciuto come distinto e valido nella sua unicità, imparerà a vedere sé stesso come un individuo separato e a sviluppare un senso di sicurezza nelle relazioni. Se questa consapevolezza non viene pienamente sviluppata, l’individuo può vivere le relazioni con un forte bisogno di fusione, vedendo l’autonomia dell’altro come una minaccia. Nelle relazioni adulte, la difficoltà a distinguere l’altro da sé può portare a vissuti di possesso e all’incapacità di tollerare la libertà del partner. L’idea che l’altro possa provare interesse per altre persone o avere spazi personali viene vissuta con ansia e sospetto, perché il valore della relazione è legato alla dipendenza e all’esclusività assoluta.
A livello diagnostico il termine gelosia patologica non corrisponde a un disturbo specifico, ma viene considerata una componente psicopatologica di altri disturbi come disturbi psicotici, il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) o il disturbo borderline di personalità, in cui l’insicurezza e la paura dell’abbandono giocano un ruolo centrale.
S. Benvenuto, La gelosia, ed Il Mulino 2011
V. D’Urso, Psicologia della gelosia e dell’invidia. ed. Carocci 2013
R.Galliani, S.Napolitani, La gelosia. Profili di un affetto fondamentale, ed.Alpes 2020
DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, American Psychiatric Publishing, 2013