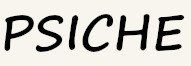Le emozioni, cosa sono e a cosa servono
Per una alfabetizzazione delle emozioni

Etimologicamente: dal latino "emovere" ovvero "ex" = fuori, più "movere" = muovere: portare fuori, smuovere, scuotere, agitare.
Le emozioni sono degli stati temporanei soggettivi in risposta a stimoli-evento (ovvero sensazioni e accadimenti che sperimentiamo personalmente), caratterizzati da:
1. MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE. Uno stimolo piacevole o spiacevole produce su di noi una modificazione corporea, che può manifestarsi in modo diverso da individuo a individuo. Tali cambiamenti corporei vanno dalla variazione della sudorazione, all'accelerazione o rallentamento del battito cardiaco (tachicardia, bradicardia, arresto), alla variazione della pressione sanguigna, all'alterazione del ritmo della respirazione (affanno, apnea), alla contrazione o rilassamento muscolare (fra cui quello dell'iride, che provoca la variazione del diametro pupillare), al battito ciliare, ai disturbi all’apparato gastrointestinale (secchezza orale o ipersalivazione, nausea, vomito, gastrite, diarrea).
2. ATTIVAZIONE di PROCESSI CONOSCITIVI: lo stimolo o l'evento attiva processi attentivi focalizzati oppure iperfocalizzati verso stimoli di attivazione; favorisce i processi di memorizzazione a lungo termine; stimola il pensiero, in particolare l'elaborazione di strategie creative del problem solving.
3. COMPORTAMENTI ESPRESSIVI: la risposta allo stimolo-evento non è solo fisiologica, subito dopo si traduce nella messa in atto di un comportamento, che si manifesta in espressioni facciali (sorriso, corrucciamento, pianto), nella variazione della voce e dei movimenti del corpo, nelle reazioni istintive di risposta alla minaccia, quali l'attacco, la fuga, la paralisi (momentanea).
Le emozioni sono dunque un fenomeno complesso e multicomponenziale.
Esse svolgono diverse funzioni:
a) FUNZIONE ADATTIVA, svolge una funzione fondamentale nell'adattamento all'ambiente circostante: quali segnali corporei in risposta agli stimoli ambientali le emozioni servono come indicatori per comprendere se stiamo agendo nel modo più adeguato alla situazione. Funzionano cioè sia come sistema di allarme rispetto a situazioni di pericolo, minaccia o perdita, sia come sistema di conferma delle nostre risposte più adeguate indicandoci se sono in grado di soddisfare i nostri bisogni;
b) FUNZIONE COGNITIVA: hanno un ruolo centrale nel funzionamento dei processi COGNITIVI in quanto focalizzano l’attenzione verso eventi rilevanti, pensieri o stimoli, organizzano i processi cognitivi, così come potenziano la motivazione e la memoria;
c) funzione COMUNICATIVA ed EMPATICA: le modificazioni corporee comunicano al cervello la valenza e l’intensità dello stimolo e dunque ci informano del nostro stesso stato emotivo (prima sorridiamo poi ci rendiamo conto di essere contenti); inoltre permettono di comunicare con gli altri, paraverbalmente (tono, timbro, intensità, ritmo della voce) e non verbalmente (cambiamenti corporei: sudorazione, arrossamento, ritmo del respiro, pressione sanguigna, contrazioni muscolari, tremori...), manifestando l’impatto che gli eventi o le azioni altrui hanno su di noi; consentono infine agli altri, osservatori esterni, di empatizzare e di impegnarsi in soluzioni senza dover sperimentare l’evento stesso.
In termini cognitivo-comportamentali le emozioni sono risposte alle interpretazioni che l'individuo dà alla dimensione psico-sociale dell'ambiente cui appartiene: l’ANSIA è il prodotto della percezione di minaccia, una sensazione di paura diffusa e non ben individuata per un ambiente genericamente pericoloso; la PAURA è invece il senso di pericolo per una minaccia individuata; la RABBIA è il frutto della percezione di attacco o della minaccia che stiamo per perdere di qualcosa; l'INFELICITA' il prodotto della percezione della perdita delle proprie fonti di soddisfazione, dell'autostima e della sicurezza; la GELOSIA è la sensazione di perdita di un rapporto esclusivo; l’INVIDIA il desiderio non meritato di qualcosa posseduto da altri; il SENSO DI COLPA è frutto di un conflitto interiore fra le proprie pulsioni e la propria coscienza morale; la VERGOGNA la sensazione di umiliazione per essere scoperti a compiere un’azione colpevole; la GIOIA deriva dalla soddisfazione delle esigenze di realizzazione (successo, senso di autoefficacia) o di affiliazione (bisogno di appartenenza, di coppia o di gruppo); la TRISTEZZA è il senso di perdita di un oggetto o di una relazione (perdita di affiliazione); la SORPRESA la sensazione di inaspettato di fronte a un evento imprevisto positivo o negativo che sia; il DISGUSTO la sensazione di rifiuto o repellenza. Come risulta evidente da queste descrizioni ogni emozione costituisce un utile indicatore su come orientare le nostre azioni: se l'emozione è positiva, ovvero piacevole, significa che dobbiamo continuare a comportarci nello stesso modo, se l'emozione è negativa o spiacevole allora si tratta di cambiare il nostro comportamento in funzione della soddisfazione dei bisogni che quella stessa emozione ci indica. In questo senso le emozioni sono tutte positive, cioè non vanno represse o negate, ma accolte e comprese.
Non è possibile, di fatto, individuare categorie discrete di emozioni, le une possono sfumare nelle altre, contaminarsi, incrociarsi, limitarsi. Sono state individuate tuttavia cinque emozioni di base: rabbia, paura, gioia, amore e tristezza. Si tratta di emozioni universali, in quanto appartengono al linguaggio non verbale che le persone della maggior parte delle culture usano per designarle, e in quanto sono innate, ovvero ad esse si associano gli stessi fattori biologici in tutti gli esseri umani.
Si distinguono emozioni primarie, originarie e innate, le prime a presentarsi nei bambini: gioia, tristezza, paura, rabbia, disgusto; emozioni secondarie, sviluppate in seguito a un processo di socializzazione e autoconsapevolezza: ad esempio disapprovazione, amore, vergogna, rimorso, senso di colpa. Emozioni complesse, stati emotivi anche contraddittori possono coesistere o dar vita a emozioni nuove: ad esempio tristezza più sorpresa forma la delusione, gioia più fiducia forma l’amore, disgusto più rabbia forma il disprezzo e così via. Le emozioni fondamentali sono universali.
Le emozioni hanno una duplice dimensione: una valenza, ovvero l’emozione può essere positiva o negativa, nel senso che può produrre sensazioni e pensieri piacevoli o spiacevoli e un’intensità, ovvero il grado di attivazione delle risposte corporee coinvolte.
Le emozioni come detto svolgono un ruolo fondamentale in rapporto con la MOTIVAZIONE. La motivazione è la spinta soggettiva che fa muovere verso un obiettivo, è cioè il bisogno che preme affinché un dato comportamento venga attivato. Poichè l’emozione, come risposta a una sollecitazione ambientale, può essere positiva o negativa, come tale funge da rinforzo per la motivazione: gli stati emozionali piacevoli rinforzano tutti quei comportamenti che li hanno determinati, motivando l’individuo a metterli in atto di nuovo (rievocazione), mentre emozioni spiacevoli rinforzano l’opportunità di non ripetere comportamenti ad esse associati. Le scienze neuropsicologiche hanno verificato anche come le emozioni influenzino la MEMORIA poiché i processi di acquisizione, consolidamento e recupero sono strettamente legati con la valutazione della valenza emozionale dello stimolo stesso. Se le emozioni sono positive, facilitano i processi di memorizzazione, mentre le emozioni negative tendono all’oblio o, in termini psicoanalitici, alla repressione/rimozione.