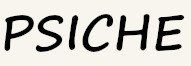La comunicazione è relazione
“Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione.”
Zygmunt Bauman
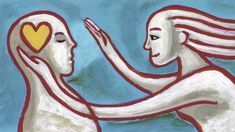
La parola comunicazione deriva dal latino “cum”, con, e “munire”, legare.
Ogni comunicazione è innanzitutto relazione.
Paul Watzlawick e la Scuola di Palo Alto, negli anni ‘70, delinearono la teoria della comunicazione umana, un riferimento incrollabile nell'ambito degli studi su questo argomento. La comunicazione non è intesa come un processo interno che emerge dal soggetto, ma piuttosto come il frutto di uno scambio di informazioni che ha origine in una relazione fra due o più soggetti. Watzlawick individua cinque assiomi della comunicazione, ovvero cinque principi di base, che vengono considerati veri senza necessità di dimostrazione, che regolano il funzionamento della comunicazione umana. Tali principi della comunicazione, se compresi e ben usati, consentono di raggiungere una comunicazione efficace.
- IMPOSSIBILITÀ DI NON COMUNICARE (1°assioma): ogni comportamento comporta una comunicazione. Anche il silenzio. Dal momento che è impossibile non comportarsi, è impossibile non comunicare. La comunicazione può essere dunque involontaria, non intenzionale, non conscia e anche inefficace, ma avviene comunque.
«L’uomo che guarda fisso davanti a sé mentre fa colazione in una tavola calda affollata, o il passeggero d’aereo che siede con gli occhi chiusi stanno entrambi comunicando che non vogliono parlare con nessuno, né vogliono che si rivolga loro la parola, e i vicini di solito “afferrano il messaggio” e rispondono in modo adeguato lasciandoli in pace. Questo, ovviamente, è proprio uno scambio di comunicazione nella stessa misura in cui lo è una discussione animata»
«L’attività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri, e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro» .
(Watzlawick)
- Nella comunicazione esiste un LIVELLO DI CONTENUTO E UN LIVELLO DI RELAZIONE (2°assioma): ogni comunicazione umana ha un livello di contenuto, relativo alla componente di informazione trasmessa, e un livello di relazione, relativo ai ruoli dei comunicanti. Nella comunicazione non è importante soltanto il significato del messaggio in sé (livello di contenuto), ma anche il modo in cui la persona che parla vorrebbe essere compresa (livello di relazione). L’aspetto del contenuto corrisponde a ciò che trasmettiamo verbalmente, l’aspetto relazionale fa riferimento alla modalità in cui comunichiamo il messaggio, il non verbale, vale a dire i gesti, l’espressione facciale, il tono di voce, la postura e la prossemica, il contesto. Il livello non verbale della comunicazione è quello che determina e influenza il contenuto. Ogni comunicazione comporta cioè una meta-comunicazione che ci parla della relazione tra le persone che stanno comunicando, se si tratta di un superiore-dipendente (modo comunicativo: ordine) di amici (modo comunicativo: compresione), o amanti (modo comunicativo: trasporto emotivo)
«Quanto più una relazione è spontanea e “sana”, tanto più l’aspetto relazionale della comunicazione recede sullo sfondo». (Watzlawick)
Una relazione “malata”, invece, è caratterizzata da una incessante lotta per definire la natura della relazione e il “contenuto” di una comunicazione passa in secondo piano.
- LA PUNTEGGIATURA della SEQUENZA DI EVENTI (3°assioma): la comunicazione dipende dalla “punteggiatura”, ovvero dalla sequenza degli eventi, il prima-dopo che viene interpretato come causa-effetto, azione-reazione. La punteggiatura è fondamentale in un flusso comunicativo in quanto è in grado di organizzare gli eventi comportamentali. Regola l’interazione, il livello e l’intensità relazionale. Un aspetto chiave della comunicazione è che ciascun interlocutore crede che la condotta altrui sia la causa della propria condotta, quando in realtà la comunicazione è un processo molto più complesso e non può essere ridotto alla semplice relazione causa-effetto. La comunicazione è un processo reticolare e ciclico. Ognuno intende un messaggio secondo la propria punteggiatura, organizza la comunicazione secondo il proprio schema causa-effetto, azione e reazione e si convince che questa sia l’unica realtà. L’effetto di questa “chiusura” potrebbe conduce a uno stallo, il paradosso dell’infinito: «Io mi chiudo in me stesso perché tu mi accusi» e «Io ti accuso perché tu ti chiudi in te stesso». Per questo è importante riuscire ad avere la capacità di ascoltare, di sospendere la propria lettura degli eventi e mettersi nei panni degli altri, per riuscire a comprendere anche le interpretazioni altrui e integrarle con le proprie, cogliendo così la circolarità della comunicazione, cadono le accuse e le colpe, ognuno è al contempo causa ed effetto, attivo e reattivo.
- COMUNICAZIONE DIGITALE (SIMBOLICA con codice) E ANALOGICA (4°assioma): La comunicazione
analogica usa la
somiglianza tra il segno linguistico e l’oggetto della comunicazione. In questo tipo di comunicazione il segno ha “qualcosa” di simile (una analogia) al concetto che si vuole esprimere, è un ponte fra significante e significato. Il disegni realistico di un albero trasmette il significato di albero, il significante è trasparente al significato. Al contrario la parola "a-l-b-e-r-o" oppure "t-r-e-e", non hanno alcun rapporto di somiglianza con l'albero e pertanto necessitano di un codice, una regola convenzionale che stabilisca la corrispondenza fra significato e significante. La comunicazione digitale
è
simbolica, ovvero lega insieme (letteralmente "mettere insieme", dal greco. sym-, "insieme" e βάλλω (ballo) "gettare", "mettere" ) due elementi fra loro dissimili, un significante come la parola "a-l-b-e-r-o" e il suo significato. La comunicazione simbolica per eccellenza è quella delle parole. la comunicazione digitale ha dunque a che fare con la scelta delle parole e la costruzione logica delle frasi, secondo le strutture grammaticali e sintattiche della propria lingua. La comunicazione analogica invece si avvale del linguaggio non verbale (gesti, espressione facciale, postura, prossemica) o para verbale (tono, timbro, intensità e ritmo-velocità della voce) e veicola la relazione stessa, la valenza emotiva e la posizione (ruolo, superiore, inferiore, paritario) che si ha nella relazione.
- INTERAZIONE SIMMETRICA E COMPLEMENTARE (5°assioma): questo assioma parla del modo in cui ci si relaziona con gli altri: talvolta in condizioni di uguaglianza, mentre altre, di disuguaglianza. Le interazioni fra due interlocutori possono essere simmetriche, quando i comunicanti sono o si percepiscono allo stesso livello sul piano della relazione: nessuno prevale sull’altro. Nell’interazione complementare si hanno due diverse posizioni dei comunicanti: uno che assume la posizione di superiore, primaria o one-up e l’altro la posizione secondaria, inferiore o one-down. In molti casi e quando i ruoli non sono naturali (es. rapporti madre-figlio) o formalizzati (es datore di lavoratore-dipendente), le relazioni complementari possono essere imposte dal contesto socio-culturale (es. medico-paziente, insegnante-alunno). Nella relazione simmetrica, ci si muove sullo stesso livello, c’è una condizione di uguaglianza e un ugual potere durante lo scambio comunicativo, ma non ci si integra. Se la relazione è complementare, come per esempio, nelle relazioni padre-figlio, maestro/alunno o medico/paziente, ci si trova in condizioni di disuguaglianza, ma accettando le differenze è possibile che l’interazione venga compiuta.
Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.,
Pragmatica della comunicazione umana, 1967